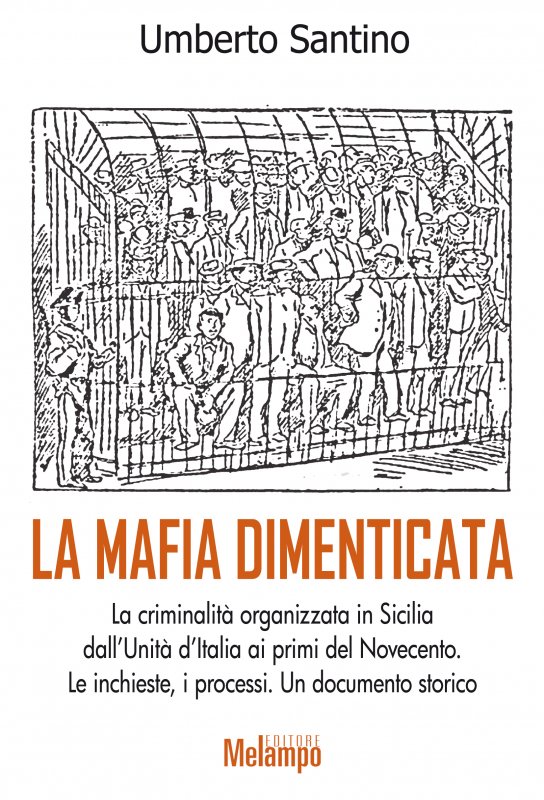Una recensione al libro “La mafia dimenticata” di Umberto Santino a cura di Salvatore Palidda
La letteratura sulla mafia è vastissima, ma questo libro contribuisce a ricostruire in dettaglio e per un lungo periodo i fatti di mafia a partire da documenti delle autorità di polizia, della giustizia e delle autorità politiche. Questo non toglie merito alle diverse ricerche che hanno praticato anche ampie incursioni negli archivi in questo campo. Al di là delle polemiche sui meriti degli uni e degli altri, la questione che sembra importante riguarda ovviamente l’interpretazione e la finalità dell’uso delle fonti. Da decenni Santino contribuisce alla decostruzione puntuale delle idee discutibili sulla mafia e le mafie. È utile ricordare che questa/e non vanno intese come attori razionali; tutti gli attori sociali e istituzionali sono caratterizzati dalla coesistenza fra razionalità e irrazionalità che è comune a tutti gli esseri umani e quindi a tutte le costruzioni sociali. La mafia eè un attore sociale che in certi casi e congiunture ha avuto e ha un ruolo molto rilevante nell’organizzazione politica della società in quanto specializzato nella “rendibilità” economica e politica del crimine innanzitutto come power broker, caratteristica che la classe dominante locale siciliana – come quella di altri paesi – si forgia proprio nel negoziare il suo ruolo rispetto ai dominanti di turno nello spazio euro-mediterraneo e quindi in Sicilia. Questo aspetto – spesso ignorato – rinvia a riferimenti alla storia degli affari militari e degli affari di polizia e quindi al ruolo geostrategico della Sicilia nello spazio euro-mediterraneo per il cui dominio è appunto indispensabile la negoziazione con le classi dominanti locali che alienano tale ruolo in cambio di una certa gestione autonoma della società locale (è qui che nasce la mafia come power broker).
Il libro di Santino è utile perché si serve dei documenti d’archivio anche per capire il presente. La mafia dimenticata è un lavoro certosino, ben curato e che si legge anche come una sorta di lungo romanzo assai appassionante. Si tratta appunto della ricostruzione dei fatti di mafia che vanno dal periodo precedente l’Unità d’Italia (con accenni frequenti anche al 1848) sino all’inizio del XX secolo. Avvalendosi anche del preziosissimo aiuto di archivisti e sostenitori del Centro Impastato nella raccolta e selezione di una gigantesca quantità di documenti a volte difficilmente decifrabili, Santino passa in rassegna le diverse informazioni, interpretazioni e tesi sui fatti di mafia citando continuamente gli originali e non mancando di fare allusioni precise a come il cosiddetto fenomeno mafioso nelle sue diverse manifestazioni si sia riprodotto sino ai giorni nostri. Non si tratta di una noiosa disamina da mafiologo proprio perché racconta fatti, descrive contesti e personaggi, i vari mondi in cui la mafia appare e scompare: essa è allo stesso tempo un segreto di pulcinella e un oggetto di elucubrazioni incredibili o aberranti da parte di intellettuali e commentatori di ogni sorta. Ma per i parenti delle vittime e per i sopravvissuti – a volte solo temporaneamente – non c’è bisogno di congetture: o s’è ben capito chi, come, quando e perché ha compiuto il crimine contro di loro o s’è deciso di rinunciare a capire, pensare e parlare. Per salvare la pelle o per sposare la causa degli autori del delitto.
Il primo aspetto impressionante della ricostruzione che propone Santino è che per certi versi nel XIX secolo si parlava di fatti di mafia molto di più di quanto se ne parla oggi. E in maniera esplicita, con accuse e contro-accuse sui media di allora, nei discorsi pubblici e nelle relazioni di servizio delle autorità locali che non erano mai mistero per mafiosi e giornalisti. Gli attacchi reciproci fra autorità dello stesso Stato o sui media sono continui; prefetti o questori contro magistrati e addirittura ministri contro altri ministri. Per esempio è inimmaginabile oggi che un questore scriva che il capo del tribunale è connivente oppure che qualche funzionario dello stato scriva che il questore è colluso con mafiosi. I recenti casi di accuse e controaccuse di funzionari passano oggi nella rubrica dei depistaggi e trame dei servizi segreti producendo la moltiplicazione di verità confuse con falsità e favorendo un complottismo che ha appunto un notevole ruolo fuorviante; infatti, è utile a impedire una parresia efficace anche nelle indagini giudiziarie che restano sempre ipotecate da norme di uno stato di diritto che assicura spazi per la legittimazione anche di ciò̀ che è illecito. En passant, è opportuno ricordare che non è certo il giustizialismo e l’esasperazione della penalità che serve nella lotta alle mafie se si capisce che queste sono intrinseche non già a una sorta di biologia delle società che ne sono marchiate, ma all’assetto economico e politico che si riproduce sempre come l’asimmetria di saperi e di mezzi a favore di pochi.
La realtà della mafia era allora talmente acclarata che quegli stessi che la negavano (e dopo l’hanno negata), proprio negandola la legittimavano e ne esaltavano la forza pervasiva.
Lo storico Paolo Pezzino – ampiamente citato da Santino – osserva che la girandola di funzionari evidenziava una fondamentale impotenza del governo, incapace di risolvere i ripetuti contrasti fra magistrati e funzionari statali: “i primi denunciavano le pratiche illegali dei secondi…” (in pochi anni si erano succeduti ben dieci prefetti, cinque questori e sei procuratori generali). Ma si trattava di incapacità oppure di una modalità utile al dominio che gioca sulla ingovernabilità che però persegue con profitto il suo obiettivo principale di difesa del patto fra borghesia del nord e rendita fondiaria del Sud?
La questione mafia aveva una rilevanza economica, sociale e politica tale da essere oggetto di inchieste parlamentari e private che oggi nessuno sembra immaginare. Per esempio, perché oggi nessuno propone un’inchiesta parlamentare sulle economie sommerse e le loro connessioni con neo-schiavitù, caporalato, violenze, collusioni con la criminalità organizzata, corruzione, evasione fiscale, ecc.? Non è forse perché si scoprirebbe che gran parte della finanza e delle attività economiche considerate legali si nutrono di tali economie sommerse che sono più del 32 % del PIL attuale? (stima plausibile se si va oltre quelle mainstream che di fatto ne coprono una buona parte). In altre parole, non si evidenzierebbe così che il capitalismo si nutre degli illegalismi tollerati e delle prestazioni che forniscono le organizzazioni criminali di tipo mafioso?
Sebbene segnate da aspetti ambigui, limiti e lacune varie, le inchieste sulla Sicilia di allora svelano a tutti fatti e situazioni di un popolo massacrato, umiliato, inferiorizzato, anche perché considerato alla stregua dei popoli colonizzati, se non animali senz’anima come asseriva Colombo a proposito dei nativi d’America, animali che agiscono per istinto, incapaci di pensare. Un popolo che non merita compassione perché è descritto come i selvaggi delle colonie e complice del peggio (bollato come avvezzo agli illegalismi che i dominanti tollerano per meglio praticare i loro illegalismi). Le categorizzazioni negative dei siciliani e della Sicilia tutta, come del meridione in genere, saranno teorizzate da Lombroso e dai suoi discepoli, fra i quali il siciliano Niceforo, del quale Colajanni sintetizza così il pensiero:
… la razza maledetta, che popola tutta la Sardegna, la Sicilia e il mezzogiorno d’Italia, ch’è tanto affine per la sua criminalità per le origini e pei suoi caratteri antropologici alla prima, dovrebbe essere ugualmente trattata col ferro e col fuoco – condannata alla morte come le razze inferiori dell’Africa, dell’Australia ecc. che i feroci e scellerati civilizzatori dell’Europa sistematicamente distruggono per rubarne le terre [1].
Nella relazione di minoranza della commissione parlamentare del 1874 si chiede un’inchiesta a vasto raggio e approfondita per conoscere il radicamento della mafia nei pubblici servizi, su come è speso il danaro pubblico, sulla concentrazione della proprietà fondiaria, sulle remunerazioni dei contadini, su industrie e miniere, sugli otto decimi della popolazione che è nullatenente, sull’analfabetismo che in Sicilia tocca l’87%. Tutte queste questioni si riassumono in una sola: “La popolazione è tiranneggiata da una vasta e potente associazione di malfattori che rende inefficace la forza della legge …”. Ma nella relazione non si dice che la traduzione pratica della “legge” è appunto quella di lasciar morire o lasciar vivere (tanatopolitica e biopolitica, come suggerisce Foucault) a piacimento del dominio che conviene a livello nazionale, ossia la perpetuazione di una sorta di feudalesimo intriso di mafia che serve allo sviluppo industriale del Nord e alla borghesia mafiosa al Sud. E, come mostra Santino, tale perpetuazione è garantita da una classe dominante locale che di fatto agisce come quella dei secoli precedenti, cioè come una sorta di power broker (concetto di Anton Blok) che si assoggetta al dominante di turno per avere libertà di dominio locale sulla pelle della maggioranza della popolazione e “mangiando e facendo mangiare” i suoi sgherri e servi fedeli, garantendo anche il consenso elettorale al governo, con la solerzia di politici siciliani e meridionali fra i quali spicca il caso esemplare di Crispi. Come dice Colajanni, il “governo è re della mafia”. Le modalità con le quali i “nuovi territori” meridionali vennero retti da politici e funzionari del giovane Regno d’Italia e le pratiche coloniali e imperialiste al tempo in auge nei territori europei d’oltremare erano simili. “La nostra cronaca africana narra cose vergognose. L’insipienza fu pari alla corruzione; questa pari alla crudeltà; si conoscono fatti scandalosi, disonesti favoritismi e sfacciate ladrerie, si sanno da tutti le stragi e gli atti orribili di giustizia sommaria colà perpetrati. E pensare che eravamo andati là per civilizzare i barbari!” [2]. Nelle imprese eritrea e poi libica gli atteggiamenti di spoliazione adottati dal governo centrale non erano diversi da quelli che, nel sud della penisola, si fondavano sulla stessa base “scientifica”: la scoperta della razza [3].
Come osservava Gramsci: il “blocco sociale” costituitosi all’indomani dell’Unità d’Italia tra industriali del Nord e proprietari terrieri del Sud esigeva perentoriamente di non intaccare il latifondo. E Gramsci leggeva l’attivismo coloniale dell’età crispina come una risposta politica ai problemi sollevati dalla questione meridionale e non come una necessità economica del capitale nazionale [4]. Bertacchi giungerà a teorizzare esplicitamente la necessità di un’espansione verso l’Africa proprio come una risposta a quel «naufragio di tutti i “progetti di colonizzazione interna” [5]. Lo storico Francesco Barbagallo sottolinea che «La tutela dei diritti dei lavoratori, la libertà di sciopero non era garantita dai governi liberali nei confini del Sud, perché qui vigeva la legge del dominio repressivo assicurato alla proprietà terriera dal suo inserimento subalterno nel blocco del potere statuale che dirigeva al Nord e dominava al Sud la società italiana» [6].
Come scrivono diversi autori persino in relazioni ufficiali, i militi a cavallo sono “briganti pagati dal governo, vivono di scrocco, fanno false denunce e l’ispettore dei militi è il primo maffioso della provincia” (p.163). Il prefetto di Palermo Rasponi rivela: il problema è l’onestà della polizia, “nell’azione della questura ci entravano per molto gli elementi maffiosi del paese”. Ma nella sua relazione conclusiva dell’inchiesta parlamentare Bonfadini sostiene che in Sicilia non esiste né una questione politica, né una questione sociale” (che considera “morbo delle moderne nazioni”). Infatti la questione politica è risolta con le repressioni sanguinose e senza limiti di ogni rivolta popolare, di ogni sussulto che possa minacciare l’ordine politico come avviene in particolare con i fasci siciliani o anche tentativi di alternative al sistema di assoggettamento dei lavoratori della terra o delle miniere. I mafiosi sono indispensabili alla polizia e ai carabinieri per eliminare il banditismo e per far fallire le mobilitazioni dei lavoratori sia infiltrandosi e manipolandole sia eliminandone i leader così come fu fatto anche nel secondo dopoguerra. In un contesto terribilmente pervaso dall’agire mafioso, di fatto protetto dal potere politico (che a sua volta ne riceve protezione), le rivolte popolari sono spesso inquinate da elementi mafiosi che appunto mirano a controllarle, manipolarle e sabotarle.
“In Sicilia non vi fu mai concetto amministrativo di sicurezza pubblica, non vi fu mai questura organizzata in Palermo dal 1860 al 1875; si diffida del segreto dei funzionari di polizia; le bande di malfattori ricevevano visite e tenevano relazioni col personale della pubblica forza” (p. 188). Non si tratta di democratizzazione della violenza ma, come scrive lo stesso Franchetti nella sua celebre inchiesta, di “facinorosi della classe media”: una classe che per la sua riuscita economica e sociale (e poi politica) coglie l’occasione di trarre rendita dalla capacità di minacciare e anche di dare la morte, facoltà che di fatto lo Stato condivide con la mafia. E ciò perché questa garantisce l’ordine: questo “paradigma” o modello o modalità diventa esplicito proprio con il governo Crispi, che fra l’altro legittima l’assassinio di Notarbarolo. E scrive Santino: emerge quindi una borghesia mafiosa che dimostra capacità concrete in campo economico, di regolazione sociale e politico grazie all’intesa col potere nazionale. “Mentre l’azione di governo è efficacissima e pronta contro i disordini popolari, rimane miseramente impotente contro quelli come il brigantaggio e la mafia si fondano sopra la classe abbiente o almeno sopra la parte dominante di essa” (Franchetti, in Santino p. 197). E Sidney Sonnino aggiunge: “La Sicilia lasciata a sé troverebbe il rimedio: stanno a dimostrarlo molti fatti particolari e ce ne assicurano l’intelligenza e l’energia della sua popolazione e l’immensa ricchezza delle sue risorse. Una trasformazione sociale accadrebbe necessariamente, sia col prudente concorso della classe agiata, sia per effetto di una violenta rivoluzione. Ma noi italiani delle altre provincie impediamo che tutto ciò̀ avvenga. Abbiamo legalizzato l’oppressione esistente ed assicuriamo l’impunità all’oppressione”. E Santino ricorda anche il commento al vetriolo di Luigi Capuana che stigmatizza la visione nordista che anche nell’analisi di Franchetti e Sonnino fa della Sicilia una regione diversa dalle altre. Da parte sua il pacifista libertario Umiltà, esule in Svizzera scrive: “il furto e l’omicidio rappresentano il solo modo di vivere che la società accorda alle popolazioni meridionali”.
Il questore di Palermo Ermanno Sangiorgi, personaggio dai costumi privati assai discutibili, è solerte, zelante nella lotta alla mafia, e allo stesso tempo si legittima rispetto al potere politico con la sua pratica altrettanto zelante per la tutela dell’ordine, colpendo gli oppositori politici e in particolare gli anarchici; non si pone molti problemi e usa il carcere preventivo persino nei confronti di militanti e persone dei quali si sa solo che hanno idee vicine a quelli degli oppositori politici del regime. Non a caso, malgrado i momenti difficili della sua carriera a causa anche delle pesanti accuse di usare e favorire anche delinquenti per colpire oppositori, riesce a raggiungere gli alti gradi della polizia (come mostra anche Benigno nel testo citato). È peraltro noto che questa è sempre a disposizione del governo e dei suoi partiti in occasione di elezioni, senza escludere persecuzioni degli oppositori al fine di impedire loro possibilità di successo elettorale. Tuttavia scrive: “i caporioni della mafia stanno sotto la salvaguardia di Senatori, Deputati ed altri influenti personaggi che li proteggono e li difendono, per essere poi, alla lor volta, protetti e difesi”.
Dopo il processo assolutorio di Milano per l’assassinio di Notarbartolo, Bissolati scrive: “Camorra e mafia sono il frutto di una politica di compressione per la quale le consorterie delle altre regioni d’Italia vogliono che si rafforzi il potere centrale con drappelli di pretoriani della Camera che vengono dal Mezzogiorno”. De Felice Giuffrida osserva: “I fasci siciliani sono la prova che se i contadini hanno delle alternative la mafia scompare”. E ancora Colajanni nel 1896 scrive: “Il questore Lucchesi, il generale Mirri ex ministro della Guerra, il senatore Codronchi in Sicilia si servirono dei mezzi mafiosi più disonesti e delle persone notoriamente appartenenti alla mafia per far prevalere i candidati governativi”.
E come scrive Santino nelle sue conclusioni, una delle più lucide letture della realtà sembra quella che propone l’anarchico Merlino, esule in Francia, scrivendo che dentro lo stato apparente legale c’è una consorteria, un trust, un Tummany Ring, insomma una cerchia intima di persone legate da interessi più o meno sospetti … quello che oggi potremmo chiamare un lobbismo mafioso che forse ha meno bisogno di usare la violenza e il dare la morte che però restano sempre sue armi in parallelo a quelle che forniscono le nuove tecnologie.
Il merito di questo volume sta non solo nel pubblicare documenti inediti e assai significativi (fra cui le relazioni di Sangiorgi, la bolla introvabile per Camilleri e Sciascia, la bolla papale (p. 104) che istituisce l’assoluzione della chiesa per i reati, quindi la monetizzazione della pena a favore della chiesa, e ancora il documento sulla cosca dell’Uditore nella veste di confraternita religiosa – p.137 – con a capo un prete delinquente a cui è dedicata una strada -padre Rosario da Partanna); il merito sta in particolare nel passare in rassegna i tanti fatti di mafia e una documentazione corposa che Santino propone con rinvii assai utili alla sua critica puntigliosa e decennale delle parziali o talvolta assai ambigue interpretazioni della mafia ancor oggi talvolta gravemente fuorvianti. Il volume racconta dei boss che parlano, anticipando di quasi un secolo Buscetta e come lui accusando gli avversari, i familiari, soprattutto le donne, che denunciano; e Santino ricorda come la protezione mafiosa sia un “sistema binario” mentre in buona parte del mondo accademico è diffusa la tesi riduttiva e fuorviante di Diego Gambetta e Federico Varese della mafia come industria della protezione privata, un istituto assicurativo.
Due soli appunti al libro di Santino: il primo è che purtroppo ci sono alcune ripetizioni spesso inevitabili vista la quantità di documenti passati in rassegna. Il secondo è che Santino sembra talvolta preoccupato soprattutto di individuare l’accezione della mafia che si evince negli scritti degli uni e degli altri, mentre forse è ancor più interessante leggere la portata antropologico-politica di questa narrazione. Una portata che ripropone una ripresa seria della discussione sul neocolonialismo interno e delle sue similarità ad altri casi. Certo il caso italiano appare a prima vista assai singolare perché alti ranghi delle autorità politiche nazionali (fra i quali Crispi ma poi tanti altri sino a Scelba) così come illustri intellettuali (vedi fra altri Niceforo) sono occupati da siciliani e meridionali. Ma questo non è stato forse il sigillo del compromesso fra borghesia del Nord e borghesia mafiosa del Sud che ha garantito e ancora garantisce (al Nord e al Sud) il processo economico italiano oggi in versione liberista? In altre parole, la classe dominante siciliana e con essa la mafia partecipa in prima fila alla formazione dello Stato unitario perché così ipoteca questo Stato, così come peraltro avvenne dopo la seconda guerra mondiale con la proclamazione dello Statuto siciliano prima della Carta costituzionale della Repubblica. Un capolavoro, appunto, per ipotecare lo stato repubblicano garantendo la perpetuità di ciò che sopra abbiamo chiamato il ruolo di power broker (re-interpretando Blok).
Salvatore Palidda
Note:
[1] Citato da V. Teti, La razza maledetta. Origini del pregiudizio antimeridionale, manifestolibri, Roma 1993, p. 97; Petraccone, 2000, p. 163; da A. Petrillo e altri. [2] Cfr. N. Colajanni, Il Madagascar e la politica coloniale, in «La Rivista Popolare politica, economica, scientifica, letteraria, artistica”, 15 dicembre 1894, a. II, n. 19, p. 645, cit. in A. Petrillo 2016 e in Dell’Erba 2006, p. 10. [3] Si vedano i lavori già citati di Petrillo e gli scritti di C. Di Piazza sugli inglesi in Sicilia. [4] Gramsci, 1929-1930/ 2007, Direzione politica di classe prima e dopo l’andata al governo, Quaderno I, § 44, in Id., Quaderni del carcere, I, Torino, Einaudi, pp. 45-46, citato da A. Petrillo 2016. [5] L’ Africa mediterranea e l’Italia, Milano 1912, p. 23, citato da Petrillo 2016. [6] F. Barbagallo, Mezzogiorno e questione meridionale: 1860-1980, Napoli, Guida 1980, p. 49, citato da Petrillo 2016.