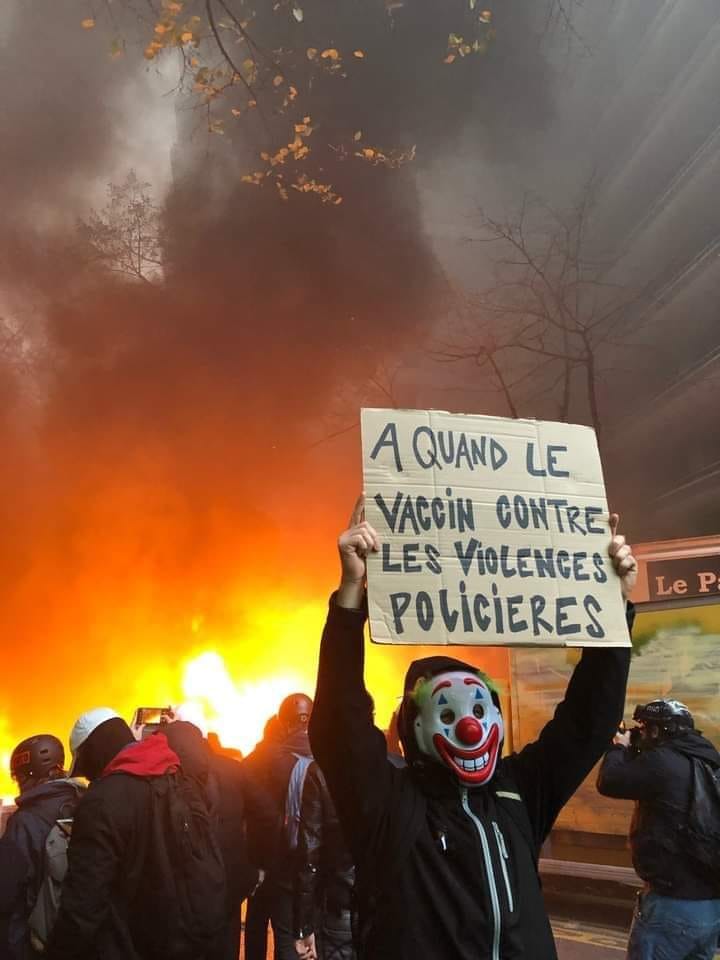L’attuale clima da pre-insurrezione che attraversa l’esagono riporta fatalmente alla memoria analoghe situazioni del 2005 e 2017…ma anche la “mort indigne” di Malik Oussekine
di Gianni Sartori
Oggi Bouna Traoré e Zyed Benna avrebbero rispettivamente 33 e 35.
Ne avevano solo 15 e 17 nell’ottobre 2005.
Due ragazzini morti prematuramente e tragicamente – o forse uccisi in modo “preterintenzionale”.
I grandi media molto parlarono o sparlarono della successiva rivolta ma spesero poche righe per dire che, 10 anni dopo, il tribunale di Rennes assolse i due poliziotti, un uomo e una donna, accusati di “mancata assistenza a persona in pericolo” per la morte dei due ragazzi, rimasti folgorati in una cabina elettrica mentre fuggivano dagli agenti a Clichy-sous-Bois, nella banlieue parigina. I due poliziotti, Stephanie Klein e Sebastien Gaillemin, sostennero di non essersi resi conto del pericolo che correvano i due ragazzi. Invece sulla radio della polizia esiste una registrazione con la voce di Gaillemin, che dice di aver visto alcune figure dirigersi verso la centrale elettrica, aggiungendo “se vi entreranno, la loro vita non varrà molto”… ma Klein e Gaillemin non mossero un dito: la vita dei due ragazzi non valeva comunque?
Dodici anni dopo (2017, cinque anni fa) soltanto chi era in malafede (o fin troppo ingenuo) poteva illudersi che le “notti dei fuochi” nelle banlieue di Parigi e di altre grandi città francesi fossero ormai un problema, se non definitivamente risolto, perlomeno sotto controllo, provvisoriamente in letargo o almeno accantonato.
Invece le gravissime violenze della polizia su un ragazzo, Théo, avevano innescato proteste di grande portata, analoghe alla grande rivolta del 2005.
Il volto “anonimo e terribile” dell’insurrezione era riapparso (come una nemesi) per le strade di Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France.
Così all’inizio del 2017 la protesta violenta dei banlieusard innalzava nuovamente il suo vessillo, nero di rabbia se non di lutto.
Talvolta definito: un “conflitto a bassa intensità” o anche “una rivolta afasica”, le periodiche sollevazioni dei giovani beurs lasciano comunque intravedere un movimento forse “in sé”, ma che sicuramente non ha ancora un “per sé”.
Sarebbe sbrigativo riportare il tutto soltanto alla “ristrutturazione del lavoro e allo smantellamento dello stato sociale”. O anche alla “globalizzazione combinata alla flessibilità che provoca inesorabilmente eccedenze ed esuberi non funzionali allo sviluppo”, come sostenevano alcune voci di sinistra. Sia chiaro: sono fattori questi che sicuramente hanno alimentato l’aumento di povertà e nuove povertà (e non solo tra gli immigrati). Non dimentichiamo che se fino agli anni Settanta l’operaio poteva ancora agire sui meccanismi economici, oggi i “nuovi poveri” (precari, “superflui”…) possono ben poco di fronte a un lavoro automatizzato e alle delocalizzazioni. E il banlieusard in particolare si scopre ogni volta cittadino di serie B, impotente, oltre che umiliato e offeso.
Nel caso dei figli di immigrati non sarebbe (o non soltanto) la “mancanza di integrazione” a determinare disagi e ribellioni. Addirittura, per lo studioso Filippo Del Lucchese, la causa potrebbe essere proprio «l’avvenuta integrazione, l’aver interiorizzato i valori di Libertà e Uguaglianza (per la Fraternità meglio rinviare a tempi migliori, evidentemente nda) scoprendo a proprie spese di esserne esclusi».
Nel 2005 per “sedare i tumulti” il governo francese era ricorso addirittura ad una legge coloniale sul “coprifuoco”. E’ partendo da questo fatto che alcuni ricercatori d’oltralpe (ma alle stesse conclusioni giungevano alcuni studiosi italiani come appunto Del Lucchese, Giuseppe Mosconi e Guido Caldiron) hanno cominciato ad analizzare la questione delle banlieue come una forma di “post-colonialismo”.
Naturalmente, ça va sans dire, le banlieue non vengono sfruttate per le inesistenti materie prime. Rimangono tuttavia, come appunto le colonie, territori in cui “la produzione dell’identità culturale avviene all’interno di un sistema di potere coloniale”*. A tale proposito Del Lucchese aveva rievocato nei suoi lavori un fenomeno ancora poco studiato dell’Ottocento, quello degli “zoo umani”. In questi luoghi gruppi di “indigeni” prelevati dalle colonie venivano esposti in vere e proprie gabbie e dovevano rappresentare la loro vita quotidiana, le danze, i riti; oppure gli “effetti benefici della civiltà”, imitando lo stile di vita dei colonizzatori. A questi spettacoli assistevano migliaia di persone. E’ stato, secondo lo studioso «un modo molto efficace di propagandare il razzismo, facendo toccare con mano la presunta superiorità dell’uomo bianco».
Di queste involontarie esibizioni esiste una vasta rappresentazione fotografica. Sono immagini molto statiche, in posa (per ragioni tecniche dei tempi del fotogramma), di “corpi immobilizzati”, domati” . Vien da dire “addomesticati”, una vera e propria imposizione di identità.
Parlando di “immagini senza storia, decontestualizzate, corpi congelati…”,
Del Lucchese si chiedeva: «Siamo sicuri che questi metodi siano veramente alle nostre spalle? Siamo certi che lo sguardo che posiamo sulle banlieue non sia sostanzialmente ancora il medesimo?».
In un suo articolo del 2005 dal titolo evocativo (“La banlieue come teatro coloniale”) metteva in evidenza quali fossero i meccanismi che producono la ghettizzazione, il vivere come colonizzati.
Come aveva spiegato Frantz Fanon (“I dannati della terra”) parlando delle popolazioni colonizzate di Asia e Africa «la loro identità è data da uno sguardo diverso dal loro». L’abitante della banlieue viene considerato “arabo” non in senso etnico, ma quasi come “un marchio di infamia” imposto dall’esterno. Ma contemporaneamente gli verrebbe “imposto di scrollarsi di dosso questo stigma”. E questo avviene non solo per i figli, ma anche per i nipoti di immigrati.
Risultato? Alla fine, azzarda Del Lucchese «recitano un ruolo, come se ancora si trovassero nelle gabbie di un nuovo, postmoderno “zoo umano”».
Dalle numerose interviste raccolte in occasione di rivolte e ribellioni emergerebbe proprio questa tendenza a “diventare quella immagine di “arabo” che altri gli hanno cucito addosso”. Sorge, ovviamente, un dubbio (non puramente “accademico”). E’ possibile che meccanismi analoghi di identificazione con uno stereotipo negativo, ma in grado di fornire comunque un’identità, siano entrati in azione anche nei tragici eventi che periodicamente hanno insanguinato la Francia (stragisti suicidi – e non; “lupi solitari”…)?
Per un altro studioso, Giuseppe Mosconi (docente alla Facoltà di scienze politiche di Padova) «sugli incendiari si dicono e si scrivono troppe banalità«. Per esempio: «si sentono esclusi, si esprimono simbolicamente…».
Certo, è più facile dire «che cosa non sono, definirli negativamente (e quindi in pratica screditarli nda), negare loro ogni dignità politica».
Mosconi sottolineava che a suo avviso «queste persone non si identificano a livello etnico- religioso, non si rifanno a improbabili “guerre sante” che oltretutto sarebbero facilmente recuperabili a livello mediatico». E, nonostante le analogie con le metropoli statunitensi, in particolare Los Angeles, non esprimerebbero nemmeno un generico “spirito di banda”. Probabilmente non aspirano nemmeno a diventare “giovani occidentali dediti al consumismo” ma forse cercano di “essere qualcosa che stanno ancora elaborando, una identità in crescita, in formazione”.
Ossia chiedono “una forma di riconoscimento che consenta loro un movimento possibile”. Intrappolati in uno “spazio ancora indistinto”, non riconducibile ad alcuna catalogazione. E’ vero, nelle banlieue mancano le strutture e il welfare quasi non viene applicato, ma la soluzione non può venire soltanto dallo stato sociale. Tantomeno , ovviamente, dalla repressione.
Quella notte a Parigi era caldo…
Ma la tragica fine di Nahel riporta alla mente, oltre quelle di Zyed Benna e Bouma Traoré, anche un’altra “mort indigne”, ancora più lontana nel tempo.
Quella di Malik Oussekine, nel caldo dicembre 1986.
Sabato 6 dicembre 1986. La mezzanotte è passata da 20 minuti.
Nel garage della Prèfecture de Paris 43 poliziotti del Peloton de voltigeurs motoportés (cagoule – passamontagna – nero e casco bianco, muniti di matraque – manganello – di legno lungo un metro) ricevono l’ordine atteso per oltre dieci ore: “PMV, en place!”.
Un’ora e mezza più tardi Malik Oussekine incrocerà la strada di questi vigilantes motorizzati. Non ne uscirà vivo.
Un passo indietro.
Nell’estate 1986 il sindacato studentesco UNEF-ID aveva lanciato una grande mobilitazione contro il progetto di riforma della scuola superiore proposto dal secrétaire d’Etat aux Universités, Alain Devaquet.
Il 22 novembre venivano convocati gli états généraux étudiants alla Sorbonne. Da qui parte l’indicazione di uno sciopero generale e di una grande manifestazione per il 27 novembre.
Intanto, rispondendo all’appello della Féderation de l’Education nationale, il 23 novembre duecentomila persone scendono in piazza contro la politica educativa del governo. Non è che l’inizio: due giorni dopo, il 25 novembre, sono già una cinquantina (su 78) le università in sciopero. Migliaia di studenti medi organizzano manifestazioni spontanee a Parigi. Il 27 sono oltre 500mila in tutte le grandi città francesi.
Il 28 novembre il governo rinvia alla commissione il progetto che stava per essere sottoposto all’Assemblea nazionale. Ma non basta: gli studenti esigono che il progetto venga ritirato, non solamente ridiscusso.
Il 29 novembre il coordinamento degli studenti conferma la manifestazione indetta a Parigi per il 4 dicembre.
E’ ormai notte sull’esplanade des Invalides. Circa 300mila studenti rimangono ancora in attesa del ritorno delle delegazioni inviate all’Assemblée e al ministére de l’Education nationale.
La risposta genera rabbia e sconforto: il progetto viene confermato.
Dopo qualche improvvisato sit-in e sporadici scontri (sul quai d’Orsay) la polizia fa uso di cannoni ad acqua e lanci di granate (causando molti feriti, alcuni gravi) per disperdere la folla.
Il giorno successivo, 5 dicembre, migliaia di studenti si riuniscono spontaneamente, anche se in maniera alquanto disorganizzata, nel quartiere Latino. Si aspetta, senza farsi illusioni, la dichiarazione di René Monory, ministro dell’Education nationale, prevista per le 20. Per il momento non si registrano disordini.
Stando ai ricordi dei presenti, la serata, rispetto ai parametri stagionali, è particolarmente douce; le persone passeggiano, si formano capannelli informali di discussione, circola molta cordialità.
Alcuni ragazzi hanno acceso un falò, ma non si vedono barricate, tanto meno saccheggi. Soltanto alcuni sacchi di sabbia vengono prelevati da un cantiere e messi di traverso, alla buona, in rue Racine. Onde evitare “provocazioni”, altri studenti sono prontamente intervenuti per togliere la simbolica barricata (alta non più di 30 centimetri).
Man mano che le ore trascorrono la piazza si va spopolando. Rimangono soltanto trecento manifestanti, in attesa di conoscere i risultati di una assemblea generale “sauvage” in corso alla Sorbonne dove il rettore ha già richiesto alla polizia di intervenire. Lo sgombero viene pianificato con cura dal prefetto Jean Paolini, dal direttore della Sécuritè publique George Le Corre e dai commissari Jean-Paul Copie e Robert Bonnet.
In campo, otto compagnie di CRS, tre squadroni di gendarmes mobiles e la compagnie de maintien de l’ordre della Prefettura. Una volta sgomberata la Sorbonne, si dovrà “ripulire” rapidamente il quartiere per evitare che gli studenti si riuniscano nuovamente all’esterno.
L’ordine di evacuazione arriva alle ore 1,08. In pratica, circa tre quarti d’ora dopo che è stato ordinato per radio al PVM di intervenire nel quartiere Latino. Questi motociclisti, definiti “unité de choc” e già noti per la loro brutalità, sono addestrati militarmente per intervenire in contesti ben più gravi. Forse le autorità sopravvalutano il numero e la combattività dei manifestanti? Si teme una riedizione del Maggio ’68 a quasi venti anni di distanza? In ogni caso, la decisione di far intervenire il PVM è quantomeno aberrante.
Intanto dalla Sorbonne gli occupanti escono con le braccia alzate e tutto sembra procedere pacificamente. Sembra soltanto. Sarebbe, secondo i testimoni, verso le ore 1 e 30 del mattino che il comportamento della polizia comincia a inasprirsi. Un atteggiamento dovuto forse alla fretta di concludere l’operazione. Il PVM piomba su alcuni manifestanti intenti a rovesciare un bidone della spazzatura in rue Gay-Lussac. L’orda di moto semina il panico, sale anche sui marciapiedi, vengono colpite persone che semplicemente rientravano a casa dal bar o dal ristorante. Alle 1 e 30, l’ala destra del plotone (sette equipaggi), guidata dal brigadier-chef Jean Schmitt, risale il boulevard Saint-Michel e imbocca a tutta velocità rue Racine inseguendo una ventina di presunti manifestanti.
E’ a questo punto che la moto di Schmitt si ribalta, probabilmente per una brusca frenata. Un ragazzo, terrorizzato dalle sirene, dal rombo dei motori, dall’evidente aggressività dei poliziotti sta fuggendo a gambe levate. Non meno spaventato, a pochi metri sta correndo anche Paul Bayzelon, un alto funzionario del ministero delle Finanze, rientrato da una cena nel momento sbagliato. Bayzelon ricorderà poi di aver pensato, sentendo i motori: “non mi picchieranno, sono ben vestito…” ma poi saggiamente comincia a correre. Dalle moto, i poliziotti colpiscono chiunque capiti a tiro. Il ventitreenne Garcia, alla sua prima missione di PVN, scende dal mezzo guidato dal collega Giorgi e comincia a inseguire a piedi i fuggitivi (contravvenendo al regolamento). Il caso, o il destino, metterà Malik a portata della sua matraque.
Arrivato al numero 20 di rue Monsieur-le-Prince, Paul Bayzelon riesce a entrare nel palazzo dove abita. Dietro di lui, terrorizzato, si getta Malik in cerca di rifugio. Bayzelon, ancora nella hall del palazzo, ne intravede il volto incollato all’esterno della porta a vetri. Dirà di essere rimasto colpito dagli occhi pieni di terrore. Gli apre e anche Malik si rifugia nella hall.
Al momento di richiudere la porta, due (o forse tre) poliziotti, tra cui Garcia e Schmitt (e forse anche Christian Giorgi, la dinamica non è mai stata completamente chiarita) entrano di forza e si precipitano su Malik massacrandolo a colpi di manganello. Lo colpiscono soprattutto alla testa e contemporaneamente lo prendono a calci nel ventre e sulla schiena. Bayzelon testimonierà che all’entrata dei poliziotti Malik aveva gridato: «Je n’ai rien fait… Je n’ai rien fait». Poi più niente, solo i grugniti dei picchiatori e i colpi sordi delle manganellate. I poliziotti escono, ma rientreranno subito, pestando anche Bayzelon, in quanto Schmitt aveva perso la sua pistola. Malik è in un mare di sangue. Verrà soccorso, comunque troppo tardi, solo casualmente. Un’ambulanza del SAMU passa per rue Racine e viene fermata da alcuni passanti. Dopo alcuni tentativi di rianimarlo, il medico si rende conto che per il giovane ormai non c’è più speranza. Finge ugualmente un ricovero d’urgenza, forse per evitare disordini data che una piccola folla si va ammassando davanti al civico 20 di rue Monsieur-le-Prince. Il resto è la triste cronaca di una famiglia sconvolta dalla notizia: Malik è morto. Ammazzato di botte dalla polizia.
Chi era Malik Oussekine?
Nato il 18 ottobre 1964, era figlio di un camionista (in precedenza minatore e muratore) di origine algerina morto nel 1978. La famiglia abitava in un HLM (casa popolare) a Meudon-la Foret. Colpito fin dalla nascita da una malattia dei reni, aveva trascorso buona parte della infanzia tra ricoveri ospedalieri, cure, controlli e trattamenti.
Stando alle testimonianza raccolte da Nathalie Prévost, all’epoca studentessa dell’école de journalisme e amica della sorella, Malik era un ragazzo educato e gentile che non parlava mai dei suoi problemi di salute. Così lo ricordava il preside della sua scuola dove si distinse per discrezione e impegno. Sempre “ansioso di vivere” incoraggiato in questo dai fratelli maggiori. Gioca a tennis, nuota, si iscrive a un corso di karaté, si allena a basket in un club. Sogna di diventare musicista, ama soul e funk. Con l’adolescenza i suoi problemi di salute si aggravano. Nel 1986 deve sottoporsi a dialisi e un fratello inizia le pratiche per donargli un rene. Malik rimane comunque un ragazzo intraprendente che ripone molte speranze nel futuro (“il est confiant dans son avvenir”). Per un anno rimane in cura presso un centro di Avon dove può continuare i suoi studi fra un trattamento e l’altro. Quando il fratello Ben Ammar lo porta a vivere vicino a lui, nel XVII, Malik si iscrive all’ESPI, una scuola di economia.
«Assiduo, puntuale, attento alle lezioni» lo ricordavano i professori. Forse un po’ solo, geloso della sua indipendenza e sempre molto reticente sulla malattia. Grazie all’aiuto dei familiari (i fratelli sono piccoli imprenditori) ha la possibilità di compiere qualche breve viaggio in Italia, Spagna e Gran Bretagna. Poi, nel settembre 1986, negli Stati Uniti presso la famiglia di un medico dove può essere seguito.
Ritorna a Parigi colmo di entusiasmo. Sicuramente molto idéaliste, non è però impegnato politicamente. Si sente francese e solo per pochi mesi frequenta l’Amicale des Algèriens en Europe e più tardi la Fusion (più che altro per curiosità secondo il fratello). Da sempre interessato alle questioni religiose, avrebbe preso in seria considerazione l’ipotesi di diventare cattolico e forse anche di farsi prete. In tasca, quando viene massacrato, aveva una copia del Nuovo Testamento. Pochi giorni prima aveva voluto incontrare due sacerdoti, P. Baudin e P. Desjobert che lo ricordano come «molto determinato, anche se forse un po’ impaziente». Sicuramente, – dicono – «Malik è stato colto dalla morte in un momento in cui stava compiendo scelte profonde». Scelte che due o tre poliziotti hanno stroncato sul nascere, à coups de matraque, quel 6 dicembre 1986.
Oggi Malik Oussekine avrebbe 59 anni.
Osservatorio Repressione è un sito indipendente totalmente autofinanziato. Puoi sostenerci donando il tuo 5×1000 e darci una mano a diffondere il nostro lavoro ad un pubblico più vasto e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram