Siamo di fronte a uno dei momenti più bui della storia del carcere repubblicano, testimoniato dalla crescita abnorme dei suicidi. Non è un semplice sovaffollamento: è l’istituzionalizzazione della crudeltà a fini di ricerca di consenso. È una strada pericolosa e illusoria. La situazione va affrontata capovolgendo l’ottica e rimettendo in campo parole e istituti desueti: numero chiuso in carcere, amnistia, indulto.
di Riccardo De Vito da Volere la Luna
Siamo di fronte a uno dei momenti più bui della storia del carcere repubblicano. L’impressione è che le parole per raccontarlo non bastino più: ‘sovraffollamento’ è un’espressione grave e importante nel gergo tecnico, ma anche asettica ed edulcorata. Un locale o una spiaggia sovraffollata sono un conto, un carcere sovraffollato è ben altra cosa, dentro c’è l’orrore. Significa che in alcune celle i detenuti non possono scendere dal letto contemporaneamente. Una banale influenza, all’interno di un camerone nel quale si fanno i conti con una promiscuità indicibile e con l’assenza della minima riservatezza, diventa un incubo capace di annientare fisico e mente. Nel carcere stipato di persone ristrette e povero di personale educativo o affine (mediatori, personale sanitario), le regole si dissolvono e la sopraffazione dei detenuti forti su quelli vulnerabili diventa più facile, se non prassi. La polizia penitenziaria non è messa in grado di formarsi, né di sperimentare culture professionali diverse da quelle deleterie delle spirito di corpo, delle logiche paramilitari, del nemico sul quale tutto è permesso. Lo psicofarmaco diventa l’unico amico della persona ristretta, l’unico sostegno di esseri umani ritorti su sé stessi come la bevitrice di assenzio di Picasso.
La via di uscita è spesso tragica: 45 suicidi tra i detenuti dall’inizio dell’anno; uno ogni quattro giorni nella descrizione statistica. Fuori dal carcere le cose vanno diversamente: nel 2020, in Europa, il tasso di suicidi registrava una diminuzione del 13% rispetto a dieci anni prima; l’Italia si collocava tra i Paesi di zona UE a più basso rischio suicidario (dati Eurostat). Ma il carcere, si sa, è un’altra terra, un mondo capovolto: è di giugno 2024 il monito del Consiglio d’Europa che evidenzia un allarmante incremento dei suicidi nelle strutture penitenziarie italiane nel giro di pochi anni (2016-2024) e invoca l’intervento urgente del governo. Nelle nostre carceri (come nei centri di detenzione amministrativa) stiamo mettendo a punto una crudeltà pericolosa, tanto più grave perché utilizzata in chiave di consenso: abituare alla disumanizzazione dei non meritevoli come premessa di una società migliore per gli inclusi, per i meritevoli. È una assuefazione pericolosa: improntata alla logica della guerra, impedisce di attivare gli antidoti emotivi e culturali contro la violenza e la pratica dei rapporti diseguali. Ma è anche illusoria: le carceri, in questo momento, sono laboratori da cui potrà fuoriuscire soltanto il virus dell’odio, della vendetta. Parliamo di questo quadro raccapricciante quando citiamo i freddi numeri: 61.547 al 31 maggio 2024, con un tasso di sovraffollamento complessivo pari al 120,1% sulla capienza regolamentare (51.241 posti) e addirittura al 129,3% su quella effettiva (circa 47.000 posti disponibili).
A dispetto dell’ammonimento del Consiglio di Europa (e del Presidente della Repubblica, 18 marzo 2024), la maggioranza politica non mostra di voler dare risposte: nessuno spazio per la liberazione anticipata speciale, ossia l’aumento dello sconto di pena che i detenuti meritevoli conseguono ogni semestre, per velocizzare l’uscita di chi ha residui di pena brevi; nessuno spazio a un serio programma di estensione delle misure alternative su base volontaria.
Le uniche risposte sembrano muoversi sul terreno della stretta repressiva. Gli eventi critici del carcere non si fronteggeranno con la prevenzione, il trattamento, l’ingresso della società dall’esterno, ma con il neocostituito Gruppo di Intervento Operativo della Polizia Penitenziaria, una sorta di squadra mobile che andrà a “risolvere problemi” – non stona il lessico truce di Pulp Fiction – negli istituti dove insorgono proteste (nota bene: l’istituzione è recente, ma l’idea è stata covata e plasmata dalla precedente maggioranza politica). È a buon punto, inoltre, il progetto legislativo di incriminare, sotto le insegne del reato di rivolta, gli atti di resistenza passiva di più detenuti di fronte agli ordini, anche illegittimi, dell’amministrazione e del personale di custodia. È una delle nuove fattispecie incriminatrici contenute nel disegno di legge 1600, sul quale l’Osce ha espresso il seguente giudizio: «The majority of the provisions carry the potential to undermine the fundamental tenets of criminal justice and the rule of law» (Opinion 27 maggio 2024). Chiaro l’obiettivo in riferimento al carcere: di fronte all’umiliazione della dignità, il detenuto deve rimanere a testa bassa.
In questa situazione, anche il solo scrivere di carcere, senza poter agire per miglioralo, risulta un problema per la coscienza. È necessario creare una forte mobilitazione che induca al cambiamento prima che sia troppo tardi. Se non riporteremo i numeri delle presenze a una soglia fisiologica, la colpa di aver accettato l’orrore ricadrà su governanti e governati, maggioranze e opposizioni, laici e addetti ai lavori. È possibile, ad esempio, che i magistrati accettino passivamente la possibilità di precipitare un condannato in una prigione che torna a essere la caverna di Beccaria?
Di alcune azioni possibile ci siamo già occupati su queste pagine. Tra queste, il numero chiuso negli istituti di pena, che possiamo così riassumere: stabilire un limite di capienza massimo per ogni istituto; non far entrare nessun detenuto oltre tale soglia; stabilire percorsi di detenzione domiciliare e controllo per chi resta fuori, con un ordine di priorità a valle che garantisca il posto ai pochi responsabili di reati davvero allarmanti. Sul tema è tornato di recente Giuliano Amato, ex Presidente della Corte costituzionale, che nel corso di un intervento nel carcere milanese di San Vittore ha descritto il meccanismo con parole chiare: «Non si entra in carcere se non c’è un posto dove andare, questo succede già in altri Paesi dove, finché non si libera un posto, non si entra». Lasciare fuori il detenuto in esubero – con le modalità di controllo cui si è accennato – non è un vantaggio indebito nei confronti di chi meriterebbe di stare dentro, ma l’unico strumento per fare in modo che il carcere non azzeri la dignità delle persone ristrette e risponda alla sua missione di risocializzazione, proprio come le altre istituzioni del welfare – in tempi di scarsità delle risorse economiche – hanno fatto del numero chiuso una precondizione per assolvere alla cura (l’ospedale) o all’istruzione (l’università).
Accanto a questa soluzione, l’ex Presidente della Corte costituzionale ha sdoganato istituti tabù a destra e a sinistra: amnistia e indulto, ritenendoli possibili nei confronti dei tanti incarcerati per reati “minuscoli”. Siamo sempre stati d’accordo: è arrivato il momento di tornare a mettere amnistia e indulto in cima all’agenda politica e di ridare agli istituti di clemenza agibilità parlamentare (ad esempio, consentendone di nuovo – con riforma costituzionale – l’approvazione a maggioranza assoluta). L’argomento nobile contro l’amnistia, da sempre, è stato uno: è una misura che ‘premia’ tutti, senza distinguere i buoni dai cattivi; proprio per questo motivo, sfoltisce la popolazione ristretta solo in via provvisoria, favorendo un’ondata di riflusso di ingressi a distanza di poco tempo.
Abbiamo constatato, tuttavia, che questo discorso vale anche per i rimedi deflattivi mirati, individualizzati e gestiti dall’autorità giudiziaria: nel corso degli undici anni che ci separano dalla sentenza della Corte EDU in materia di sovraffollamento – la celebre ‘Torreggiani’ – i magistrati di sorveglianza hanno chinato il capo su migliaia di misure alternative, che hanno favorito una effettiva decongestione del carcere, ma siamo tornati quasi al punto di partenza. La colpa non è delle valutazioni errate dei giudici, come non lo era della logica premiale indifferenziata dell’amnistia. La causa ultima del sovraffollamento, come è stato più volte rimarcato, è nell’uso politico spregiudicato e simbolico della risorsa penale, nella scelta di non rinunciare alla repressione nella guerra alla droga, nella sostituzione della sicurezza esistenziale attraverso la rete dei diritti con l’inganno della sicurezza pubblica mediante le chiavi da buttare.
Ecco perché l’amnistia deve e può tornare in agenda politica, insieme al numero chiuso. Lo ha detto il Garante dei detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasia: l’adozione di un provvedimento di amnistia – nei confronti, ad esempio, degli oltre 16.000 condannati a cui al 31 dicembre 2023 mancavano meno di due anni alla scarcerazione definitiva – si dovrebbe sposare con l’adozione del numero chiuso, affinché non si ricominci da capo, non si precipiti più nell’orrore. Sarebbe l’occasione per fare del numero chiuso un’occasione per un amnistia definitivamente utile – nessun riflusso sarebbe possibile con il numero chiuso – e per ridare al carcere la possibilità di essere un luogo umano.
È noto che il clima politico/culturale egemone è ostile a queste traiettorie, ma occorre accendere i riflettori su di esse: come detto, gli effetti del degrado umano della galera ricadranno su tutti e l’inerzia, questa volta, determinerà una colpa di portata storica. La dialettica tra gli ‘ideali’ e ‘la rozza materia’ – il profetico dualismo di Bobbio – attraversa il carcere di questo tempo. Spetta agli uomini di questo tempo, dunque, fare in modo che la seconda si arresti davanti ai primi, ridando fiato a una democrazia nella sostanza sempre più esangue.
Osservatorio Repressione è una Aps-Ets totalmente autofinanziata. Puoi sostenerci donando il tuo 5×1000
News, aggiornamenti e approfondimenti sul canale telegram e canale WhatsApp
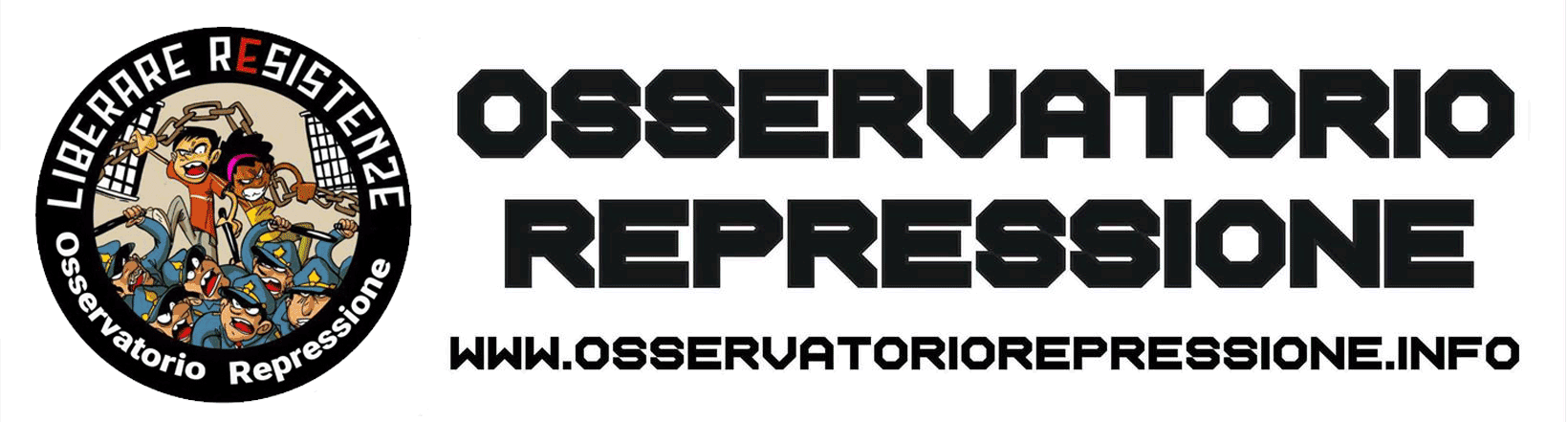


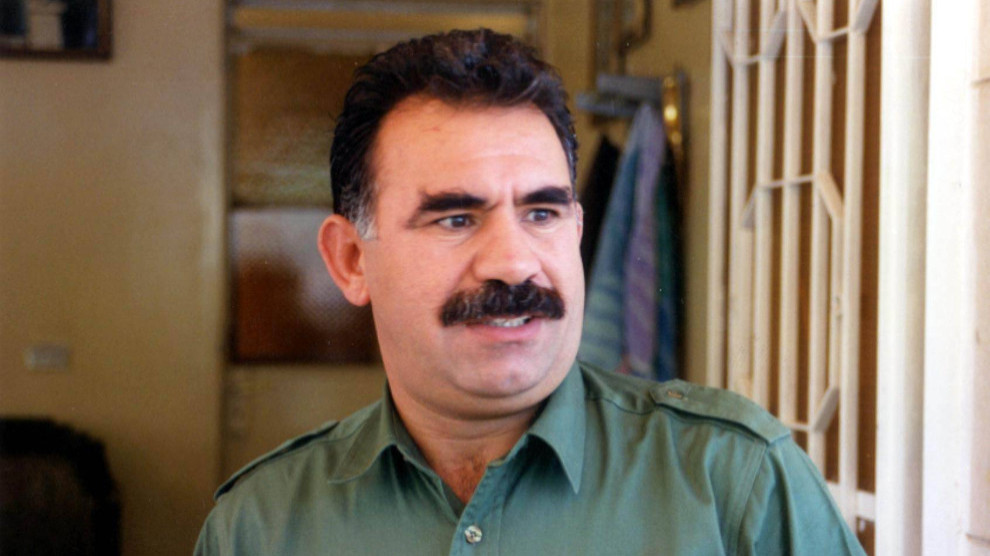
Leave a Comment