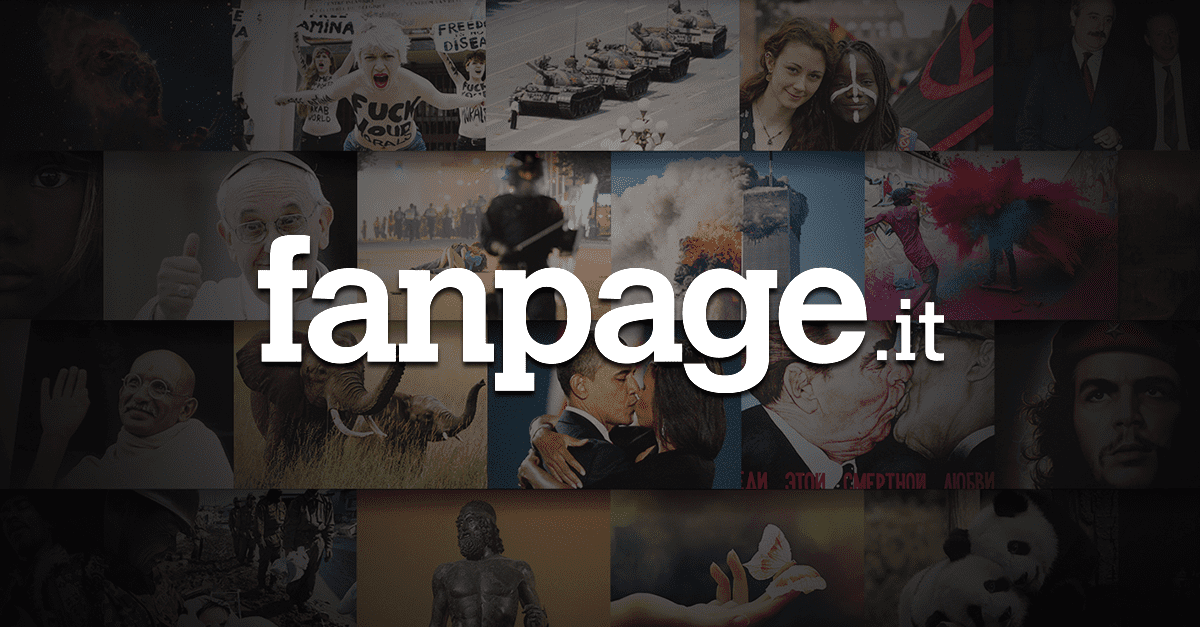Suicidi in carcere: fatti non individuali che interrogano il “sistema giustizia”
Trentanove morti in 37 settimane dall’inizio del 2021 negli istituti di pena italiani: il dato, simile al 2020, è preoccupante ma poco dibattuto. “La pandemia non sia una scusa per adagiarsi su un modello di carcere chiuso che aumenta la sofferenza dei detenuti”, spiega il professor Giovanni Torrente di Antigone.
“Quando una persona viene affidata allo Stato, quest’ultimo diventa responsabile non solo della privazione della sua libertà ma anche della tutela dei suoi diritti”. Con queste parole l’ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale commentava a metà agosto 2021 l’ennesimo suicidio all’interno degli istituti di pena. A Vicenza la persona era morta appena quattro ore dopo il suo ingresso. Il primo settembre, nel carcere di Ferrara un giovane di 29 anni si è suicidato verso le tre del pomeriggio ancora in attesa di essere sentito dal giudice per la convalida dell’arresto: era entrato nella notte, non c’è stato tempo. Sono “solo” due dei 39 suicidi in 37 settimane -dati del Garante aggiornati al 19 settembre- registrati negli istituti penitenziari italiani dall’inizio del 2021.
Un numero minore rispetto al 2020, quando al 30 settembre erano stati 50, ma significativo se si considera che nell’anno passato è stato registrato il tasso di suicidio -ovvero il rapporto tra il numero di suicidi e il numero di persone detenute mediamente presenti negli istituti- più alto dell’ultimo ventennio. “Il suicidio non è mai qualcosa di individuale ma sempre connesso al contesto in cui la persona vive. Per questo è importante parlarne, al di là delle ragioni, non conoscibili, per cui una persona sceglie il suicidio. Qualcosa si può e si deve fare”, spiega Giovanni Torrente, ricercatore all’Università di Torino, dove insegna sociologia giuridico-penale, e membro del direttivo di Antigone.
Professor Torrente, 39 suicidi in 37 settimane. Perché è un dato preoccupante?
I numeri sono l’espressione di un fenomeno che è strettamente legato alla privazione della libertà. In tutti i Paesi del mondo il carcere è a rischio per quanto riguarda i suicidi per una serie di fattori strettamente correlati. L’Italia ha un dato particolare, non proprio invidiabile, che è la maggiore distanza tra il tasso di suicidio della popolazione libera – più basso rispetto a quelli di Paesi limitrofi, come la Francia – e quello della popolazione detenuta, che aumenta in maniera evidente. Questo ci dice che l’ambiente carcerario è particolarmente a rischio.
Perché?
Negli studi che abbiamo svolto si evidenzia come le persone protagoniste del suicidio portano con sé problematiche già pregresse, gravi, rispetto a cu l’esperienza detentiva costituisce un elemento determinante nella decisione di tentare l’estremo gesto. La letteratura internazionale, d’altronde, ci dice ormai da anni come il suicidio non sia mai qualcosa di individuale: l’azione di una persona nel porre fine alla propria vita è profondamente legata all’ambiente in cui vive. Questo ci impone di affrontare questo fenomeno non soltanto da un punto di vista medico-psichiatrico, che ci deve essere, ma anche da un punto di vista organizzativo.
In che senso?
È rilevante il “clima all’interno del carcere”. Quando l’ambiente è migliore -meno sovraffollamento, maggior aspettativa di eventi positivi quali ad esempio l’accesso alle misure alternative piuttosto che un maggior impiego delle persone ristrette in attività all’interno degli istituti- ecco che i tassi di autolesionismo e suicidi tendenzialmente diminuiscono. La pandemia ha sicuramente messo in crisi il sistema andando a limitare proprio queste possibilità e ciò potrebbe aver inciso sull’alto numero di suicidi del 2020 e di questi mesi del 2021.
L’amministrazione penitenziaria poteva fare di più?
La gestione dell’universo penitenziario della pandemia ha rispecchiato pienamente le caratteristiche che siamo abituati a osservare. È stata una reazione a macchia di leopardo: in certi casi abbiamo avuto pratiche in grado, soprattutto nella prima parte, di ridurre l’impatto di un fenomeno che appariva come letale. In molti avevano ipotizzato che le carceri sarebbero diventate come le residenze per anziani ma fortunatamente nella maggior parte dei casi non è avvenuto. Questo è positivo. In altri istituti, invece, sono state messe in atto purtroppo forme di chiusura da parte dell’amministrazione e questo potrebbe aver inciso anche sui suicidi.
Ha citato il sovraffollamento come uno dei fattori che incidono sul tasso dei suicidi. Nel 2020 però la popolazione detenuta ha subito una riduzione: il 31 maggio 2020 era formata da 53.387 persone, contro le 61.230 di fine febbraio. Una cifra rimasta pressoché stabile anche nel 2021…
Attenzione a questo dato. In questo caso specifico non sono aumentate le uscite dal carcere ma sono diminuiti gli ingressi. L’ultima riduzione della popolazione detenuta è legata a questa tendenza. Ciò significa che la speranza di uscire, per chi è dentro, non si è concretizzata. Si è creato così quel fenomeno, già osservato tante volte nel passato, per cui i fenomeni di autolesionismo e di suicidio aumentano nel momento in cui le promesse di una maggior possibilità di ottenere provvedimenti di clemenza non vengono mantenute. Una volta che la speranza “crolla” la tensione sale a un livello più alto di prima. Per questo motivo la riduzione del sovraffollamento potrebbe non aver inciso così significativamente, in senso positivo, sul numero di suicidi.
Muoiono spesso detenuti giovani e con una pena non definitiva. Come affrontare questi aspetti?
Direi che sono due elementi da analizzare separatamente. L’Italia ha una delle percentuali più alte in Europa di persone non condannate a titolo definitivo presenti in carcere: i suicidi aumentano tra chi non ha una pena definitiva. Questo è un annoso problema del sistema giustizia del nostro Paese. L’aspetto dell’età, invece, riguarda più strettamente anche il sistema penitenziario. Nella ricerca compiuta qualche anno fa avevamo evidenziato il buon funzionamento dei servizi “nuovi giunti”, ovvero quel servizio di accoglienza che, soprattutto negli istituti più grandi, dovrebbe servire a monitorare l’impatto del carcere sui nuovi ingressi. Purtroppo, oggi, notiamo nuovamente un aumento di persone di giovane età coinvolte che suggeriscono come quei servizi non stiano funzionando. Su questo è necessario che l’amministrazione penitenziaria si doti di strumenti più efficaci per affrontare questi momenti. Bisogna cogliere in tempi i segnali di rischio legati al trauma dell’ingresso in istituto, che segue quello dell’arresto e della commissione del reato.
C’è un legame tra gli eventi critici che si verificano negli istituti e i pestaggi e le torture -non un caso isolato- nel carcere di Santa Maria Capua Vetere?
I fenomeni dell’autolesionismo così come quelli legati alla violenza eterodiretta devono essere letti all’interno di una prospettiva strutturale che certamente, seppur non accomunandoli pienamente, li rende meno distanti. Questi fenomeni accadono laddove il contesto è deteriorato e si verifica quel processo conosciuto come “spirale della violenza” che porta a un progressivo aumento della tensione. Se il carcere si chiude in una logica di stampo autoritario le persone patiscono di più il sistema opprimente e questo può sfociare sia in un aumento degli eventi critici, sia in una maggior violenza tra custodi e custoditi. Le immagini diventate virali in estate sono una conseguenza di questo. Il carcere è ontologicamente un contesto dove la violenza è possibile, frequente: venirne a conoscenza e poterne parlare è un aspetto positivo.
Quali conseguenze può avere la pandemia sul sistema carcere?
Il rischio è che ci si adagi su un modello di carcere chiuso, con una perdurante limitazione degli ingressi dall’esterno. Non deve succedere. I luoghi di pena possono essere democratici, potenzialmente inclusivi, laddove sono frequentati da soggetti terzi: sia volontari ma anche soggetti che frequentando il carcere lo rendono un ambiente meno duro. Così come stiamo ripartendo in vari campi è necessario che anche nell’amministrazione penitenziaria si torni nuovamente a un’apertura verso il mondo esterno. La pandemia non può diventare una “scusa” per non riprendere i processi di reinserimento che devono accompagnare l’esecuzione delle pene.
intervista a cura di Luca Rondi per Altreconomia.it